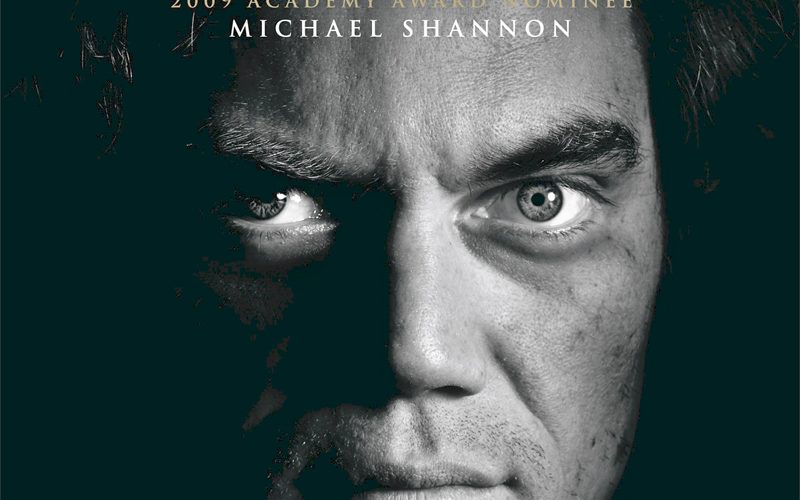Arte e vita: a separarle, un crinale sottilissimo. Lo sa bene Brad McCullum, giovane attore alle prese con l’Elettra di Sofocle. Un bel giorno, in un tranquillo quartiere residenziale di San Diego, lindo, pulito, immobile di un’immobilità che odora di morte, un bel giorno Brad uccide la madre con un’antica sciabola. Si libera, insomma, della donna che l’ha messo al mondo, che gli ha dato la vita, esattamente come Oreste ammazza Clitennestra. Arte e vita sono separati da un crinale sottilissimo sul serio, perché quella di Brad portata sullo schermo da Werner Herzog è una storia vera. My son, my son, what have ye done si ispira ad un fatto di cronaca, l’assassinio, da parte di Mark Yavorski, della madre, avvenuto nel lontano 1979. Lo script era già pronto dalla fine degli anni Novanta, ma c’è voluto un incontro con David Lynch (qui nelle vesti di produttore) per trasformarlo in un lungometraggio, presentato nel 2009 al Festival di Venezia.
Ad Herzog non interessa scovare il movente, quanto piuttosto illustrare il progressivo sprofondare del suo anti-eroe nella follia. Al diavolo, quindi, le regole della detection: con uno stile composito, che alterna flashback basati sulle testimonianze di Ingrid (la ragazza) e Lee Meyers (il regista dello spettacolo in cui recita) a passaggi onirici, il regista intreccia fatti salienti della vita di Brad (tra cui una crisi mistica avuta durante un viaggio in Cile) e allucinazioni, ricostruendo il mosaico di una personalità disturbata, preda di una gravissima forma depressiva.
Brad, dopo l’omicidio, è asserragliato in casa. Il dramma (interiore) diventa (psico)dramma pubblico quando lo spazio antistante la villetta si riempie di poliziotti e curiosi, separati dal “palcoscenico” (il luogo del delitto) in obbedienza alla rigida divisione teatrale dei ruoli. Del resto, in tutto il film la dimensione “rappresentativa” è estremamente pronunciata. «Alcuni interpretano un ruolo, altri recitano una parte», dice ad un tratto Brad a Lee. La sua, per l’Elettra e il ruolo di Oreste, è una vera e propria ossessione, che fa scattare un meccanismo di identificazione fortissimo. Dove fiction e realtà coincidono è nell’uccisione di quella madre che lo tratta ancora come un’infante e che ha le fattezze scavate di Grace Zabriskie, lynchiana di lungo corso, la cui prole (cinematografica) certo non può dirsi fortunata (in Twin Peaks aveva dato i natali a Laura Palmer…)
In Brad c’è qualcosa di affascinante, persino grandioso. Prototipo dell’eroe herzogiano, l’outsider che si muove lungo il sottilissimo crinale che separa l’illuminazione dalla pazzia, è insomma un moderno Aguirre. E non è un caso, forse, che Yavorski, nella roulotte in cui viveva dopo aver trascorso otto anni in un manicomio criminale messicano, avesse costruito un altarino intorno al poster del Furore di Dio (1972) – questo per dire del rapporto tra arte e vita…
Un senso di tragica ineluttabilità aleggia su tutto il film dalla prima all’ultima scena, al punto tale che la ricerca eziologica, del “Perché”, diventa priva di senso. Niente a che vedere, quindi, con i classici hostage-thriller: My son, my son, what have ye done è uno sguardo lucidissimo su un labirinto di follia, solitudine, disperazione, in cui non c’è catarsi e non c’è liberazione.